3 posti per una toccata e fuga

Pathos: Saragos Evo Pro
6 Ottobre 2023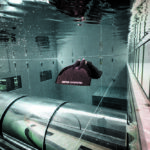
Il fascino della monopinna
26 Ottobre 2023Loano in Liguria Comacchio in Emilia Calabernardo in Sicilia. In giro per l'Italia alla ricerca di spot ove, se si creasse l'occasione, poter scendere comodamente in acqua per una fugace pescata (in barba a famiglia, lavoro e altri impegni “sociali”...)
Alberto Martignani
I 3 posti di questo mese si trovano in località di mare piuttosto note: per le spiagge rinomatissime, ma anche per le bellezze artistiche e architettoniche del loro entroterra. Sono sicuro che ciascuno di voi le conosce e ci sarà anche passato, almeno una volta. Ma chissà se ne avete anche approfittato per un tuffo!
Loano
La Liguria non rientra tra le mie mete abituali: so bene come sia difficile fare carniere partendo da terra, senza conoscere bene il territorio e i fondali. A Loano ci sono andato alcuni anni fa, quasi per caso, nel corso di un viaggio invernale verso la Costa Azzurra e siccome avevo tempo ed ero curioso, mi ci sono fermato per un’uscita.
La cittadina di Loano si colloca nella cosiddetta Riviera delle Palme, tra i comuni di Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito, una trentina di chilometri d'autostrada passata Savona. Siamo nel Ponente ligure, in una zona caratterizzata da ampi ed estesi spiaggioni, poco adatti alla pesca, tranne che a ridosso dei manufatti a protezione di porti e arenili.
Loano presenta un centro storico interessante (con monumenti che possono sicuramente giustificare una gita domenicale), una spiaggia molto rinomata e... scogliere artificiali che meritano ampiamente una visita!
D'inverno è agevole parcheggiare sul lungomare (cosa che deve risultare senz'altro più complicata durante la stagione estiva). Consiglio di lasciare l’auto al “vecchio molo” e al vicino Museo del Mare, che consente di accedere poi, con una breve camminata a piedi, a spot diversi ma adiacenti. Il primo è rappresentato dal versante esterno dell'antemurale che protegge, da sud est, il porto. E' lungo circa 500 metri e, come da Ordinanze, è fruibile lungo il suo versante esterno, sino a una distanza di rispetto dalla punta.
Conviene entrare in acqua dalla spiaggetta alla base del molo (Varesina Beach). La massicciata è costituita da una ricca franata di massoni irregolari, che formano un gradino a 5, 6 metri di profondità e una successiva caduta sino a morire sulla sabbia in una decina di metri di fondo.
Davvero una bella diga, ma forse ancora più interessante è la soffolta che si stacca verso destra circa 150 metri dall'inizio della diga. Il frangiflutti s’intravvede affiorare in superficie solo per i primi 50 metri circa, poi prosegue completamente sommerso per ulteriori 200 metri.
Inizialmente corre parallelo alla spiaggia, circa 150 metri al largo, ma nel tratto finale piega ad arco in direzione di essa, sino a congiungersi con un corto e tozzo pennello. In alcuni punti la franata di massi sommersa è larga anche più di 10 metri e la profondità d’esercizio è inferiore rispetto alla diga, non più di 4, 5 metri.
E non è tutto! Se dal pennello pinneggiamo (o camminiamo lungo la spiaggia) per ulteriori 100 metri, sino a scapolare il cosiddetto “vecchio pontile”, osserveremo come la soffolta riprenda, più o meno con le medesime caratteristiche, per oltre 200 metri.
Tutta la zona, volendo esplorarla estesamente, consente almeno 4 ore di pesca, ma ovviamente ci si può limitare al solo antemurale portuale, oppure a una o a entrambe le soffolte. Quando vi sono stato, ho trovato acqua discretamente limpida e si pescava bene con il 94 a elastici, nonostante la foce di un piccolo corso d'acqua, il torrente Nimbalto, collocata proprio tra il pennello e il vecchio pontile.
Non vidi molto, solo qualche branco di cefali e svariata mangianza di acciughine, però c'è da tenere conto che l' acqua era piuttosto fredda, sui 13 gradi, e soprattutto il mare completamente piatto, situazioni poco favorevole alla circolazione dei predatori.
Ritengo che in altre condizioni la zona possa riservare sorprese interessanti, tanto più che, proprio mentre scrivo, mi giunge voce come, nel litorale di Ponente, sia stata recentemente completata la messa a mare di un altro importante sistema di soffolte.
Comacchio
Questa storica cittadina, al centro delle omonime valli che, nonostante le bonifiche, rappresentano tuttora una delle più estese aree umide del nostro Paese, è stata rivalutata, negli ultimi decenni, anche come meta turistica. Lontani quindi i tempi in cui l’economia di Comacchio, di pura sussistenza, si basava in gran parte sulla pesca dell’anguilla. Al giorno d’oggi, sia il centro storico di Comacchio, d’impronta settecentesca e intersecato dai caratteristici canali, sia la vicina e imponente abbazia romanica di Pomposa e la grande zona naturalistica del Parco regionale del Delta, vengono visitati da centinaia di turisti ogni giorno, mentre il litorale antistante, con i famosi 7 lidi di Comacchio, costituisce a sua volta un potente polo d’attrazione.
Quasi al centro di questa piccola riviera, l’importante porto peschereccio di Porto Garibaldi che prende il nome dal fatto che fu proprio qui che approdò l’eroe dei due mondi”, con la moglie Anita, nel 1849, in fuga da Roma.
Da Porto Garibaldi verso nord, per un’estensione di quasi 9 chilometri, il litorale è protetto da una lunga teoria di barriere frangiflutto. Si tratta di ben 69 dighe, che interessano le località di Porto Garibaldi, Lido degli Scacchi, Lido di Pomposa e Lido delle Nazioni. A eccezione delle due o tre più a sud, pressochè insabbiate, sono tutte adatte per farci un tuffo, che fuori stagione è praticabile senza particolari limitazioni, mentre durante la stagione balneare occorre consultare le relative ordinanze che, in linea di massima, consentono l’immersione solo sul versante esterno delle barriere e dall’alba al tramonto (orientativamente prima delle 8 e dopo le 19).
Quindi, se capitate da queste parti, approfittatene per una toccata e fuga. Questo mare, arricchito di nutrienti dagli apporti fluviali, in particolare dal vicino Delta del Po, è infatti ancora relativamente ricco di pesce.
Tutto rose e fiori? Purtroppo no, in quanto trovare la congiunzione giusta per uscire utilmente non è scontato. Proprio la vicinanza con le foci del Po, e di altri fiumi, come il Reno, che delimita il territorio a sud, rendono spesso precaria la visibilità, che si annulla completamente per molti giorni in caso di piogge abbondanti o mareggiate.
I bassi fondali alto-Adriatici fanno inoltre sì che, sia in estate che in inverno, le temperature dell’acqua raggiungano temperature estreme (sino a 30 gradi in agosto e 5 a gennaio) che allontanano il pesce, rendendo fruibili, in pratica, le sole mezze stagioni.
Se le condizioni ci sono, non è difficile parcheggiare l’auto sul lungomare, a poche decine di metri dall’ingresso in acqua prescelto. I parcheggi sono a pagamento durante la stagione balneare e gratuiti fuori stagione.
Come dicevo, le barriere sono tutte pescabili, anche se esistono, a mio parere, punti più interessanti di altri; ad esempio, le ultime a nord, che sono le più distanti da riva (circa 250 metri) e rappresentano, praticamente, gli ultimi potenziali punti di aggregazione per i pesci, prima del delta padano. Cercando con pazienza, potrete anche individuare, in località Lido delle Nazioni, una particolare barriera che continua, sott’acqua, con un’estesa soffolta.
Più facilmente individuabili, a Lido di Pomposa, due dighe recentemente potenziate (spiccano per il colore ancora molto chiaro dei loro massi!) e pertanto caratterizzate da una franata particolarmente ricca, oppure la zona, segnalata da mede, in cui sono state deposti, poche decine di metri al largo di alcune pass, nuovi sbarramenti antistrascico, su un fondale che può arrivare, nei punti più profondi, attorno ai 5 metri.
Le prede sono quelle tipiche dei fondali Alto-Adriatici, anche se con alcune particolarità legate alle basse condizioni di salinità: spesso presenti, compatibilmente con le condizioni del periodo, le spigole, che sembrano prediligere questo ambiente e sono senz’altro più numerose che nel limitrofo territorio ravennate, dove gli apporti fluviali sono minori e dove, al contrario, prevale, come specie, la mormora.
Sempre numerosi, nella stagione giusta, i grossi cefali di passo, mentre da qualche anno si fanno vedere con regolarità i serra, anche grossi. Potreste anche incontrare qualche anguiilla, che è la specie simbolo della zona, ma ricordate che, da quest’anno, la pesca sportiva a questa specie è proibita, a causa del rischio d’estinzione che la minaccia! Va utilizzato un fucile cortissimo; ottimale, secondo me, un 50 ad aria, armato con fiocinone a 3 o 5 denti per tiri istintivi nel gran torbido!
Calabernardo
Nel Siracusano, è un caratteristico ex borgo di marinai che piano piano è diventato una località balneare dove molta gente, specie di Noto, trascorre le vacanze estive.
Proprio per la vicinanza (una decina di chilometri…) con questo gioiello
dell’architettura barocca, Calabernardo è stata protagonista di approdi eccellenti, di personalità che vi si recavano in visita, il più importante e sfarzoso dei quali fu quello di Re Ferdinando I di Borbone, evento che da queste parti viene ancora ricordato.
Altrettanto vicina è la bella città di Avola, nota per un’antica tonnara e per il celebre vitigno. Sono stato da queste parti non molti anni fa, a maggio, ospite degli amici Corrado Nastasi e Alessandro Talò, per una serie di uscite in gommone su quegli stessi fondali che, nel 2014, hanno ospitato i Campionati Assoluti. E proprio il porticciolo di Calabernardo era la base di partenza di queste uscite…
Se osservate la conformazione della costa, noterete come il borgo sorga su una specie di terrazza rocciosa, quasi rettangolare, che sporge nettamente dal profilo, per il resto rettilineo, del litorale. Da ciò nasce la denominazione di Balata (che in arabo-siciliano significa “lastra-colata”), che è la denominazione alternativa della località.
A nord, questo tavolato è delimitato dal fiume Asinaro, alla cui foce si è formata una spiaggia sabbiosa sulle cui sponde avvenne, nel 413 a.C., una famosa battaglia, in cui i Siracusani sbaragliarono il corpo di spedizione ateniese di Nicia e Demostene. A memoria dell’evento, negli anni successivi venne eretta nei dintorni del paese quella Colonna Pizzuta che costituisce il monumento più noto di Calabernardo.
A parte questa spiaggia settentrionale, per il resto il litorale è roccioso e scabro. Vi corre di fronte, parallela alla costa, un’autostrada di grotto, con strisciate di coralligeno molto traforato che consente di pescare a tutte le profondità.
Partire da terra è facilissimo. Io scendevo direttamente dalla villetta in cui ero alloggiato, percorrevo una stradina per qualche decina di metri verso destra poi, dove iniziava il lato meridionale del quadrilatero e la stradina finiva, proseguivo su un sentierino sterrato, per una cinquantina di metri, sino all’ingresso in acqua. Qui infatti, in contrada Malacala, avevo individuato un punto comodo di discesa, sul retro di un residence turistico. Accedevo, in questo modo, a un interessante bassofondo roccioso che, al tramonto, con la risacca prodotta
dall’ondina di scirocco, riservava sempre qualche incontro.
Il punto più promettente, caratterizzato da una serie di scogli affioranti sino a una quindicina di metri da riva, era esattamente quello da cui scendevo. Ricordo la prima volta: cefali e saraghetti danzavano come impazziti tra gli scogli alla ricerca dei detriti alimentari staccati dall’onda. Esattamente al terzo tuffo, l’avevo vista: dapprima un’ombra poco definita, ma enorme, che si dirigeva verso di me. Poi, piano piano, un’inconfondibile macchia dorata a caratterizzarne il muso. Un’orata di dimensioni primordiali che avevo veramente creduto di riuscire a catturare, dato che ero appostato bene, con la pesata giusta.
Unico neo: il sole di fronte! L’oratona infatti, giunta a meno di un metro dalla portata utile del fucile, quasi per un sesto senso, si era fermata, girata ed era lentamente sfilata via.
Ero poi rientrato a pinne girando in senso antiorario attorno al tavolato roccioso, con il sole questa volta prevalentemente alle spalle, avvistando qualche sarago e un barracuda, tutti però pesci smaliziatissimi, per cui alla fine avevo catturato solo uno sparide e un cefalo.
Percorsi circa 500 metri, sino a raggiungere il vecchio molo, avendo esplorato la batimetrica dal metro di profondità ai 6, 7 metri, ero risalito. Ero rimasto in acqua qualcosa meno di 2 ore. Curiosamente, quando più tardi avevo parlato con Corrado Nastasi, raccontandogli la giornaa, mi aveva confidato come quell’ orata enorme, in quel punto, a quell’ora e in quelle condizioni, c’era quasi sempre. Ne aveva prese molte, di orate, in quel posto, ma quella non era riuscita mai a sorprenderla.
Chissà che non sia ancora là…



